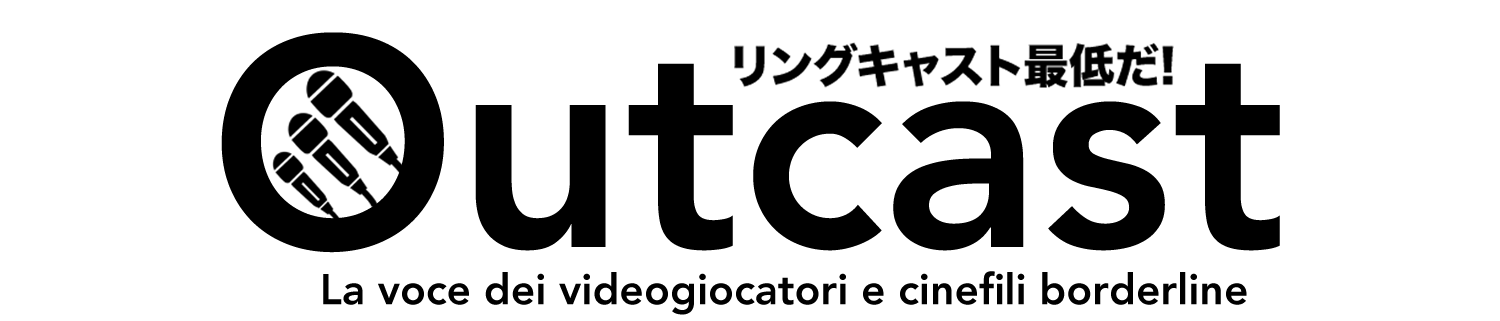Darkest Dungeon è la risposta a tutte le domande che il fantasy non ha mai il coraggio di fare
Questa via subito dalle palle.
Titoli alternativi suggeriti:
• Darkest Dungeon è il malessere strisciante e silenzioso che pervade ogni fantasy;
• Darkest Dungeon è tutto ciò che c’è di sbagliato nel fantasy;
• Darkest Dungeon non era ancora stato recensito su Outcast ed era ora.
Il terzo non era un granché e l’abbiamo scartato subito.
È curioso parlare di Darkest Dungeon all’interno di una cover story su Il trono di spade, perché per molti versi l’uno è l’antitesi dell’altro. La serie di HBO è tutta eroi, grandi nomi, titoli nobiliari, persone famose e riconoscibili anche in un mondo senza Internet, profezie e prescelti; come gran parte del fantasy, d’altra parte, se consideriamo “il signor nessuno che salva il mondo” una semplice variazione sul tema. Mica ne faccio una colpa a nessuno, è più facile raccontare una storia se si può dare un nome e una personalità a un gruppetto di personaggi, più duro è rendere interessante e anche epica l’esistenza di tutti quelli che stanno ai margini a fare il lavoro pesante e ripetitivo, schiacciati dalla ruota come dice quella là, magari vestiti con una maglietta rossa che li identifica come sicure (e anonime) vittime.
Darkest Dungeon è un gioco sulla ruota, di più: chi gioca a Darkest Dungeon è la ruota, e le figurine sotto il suo controllo sono i… grani? Ingranaggi? Possiamo fermarci un attimo su questa metafora della ruota, per favore? Di che tipo di ruota parliamo? È una ruota che schiaccia, OK. Quella di un mulino? Non si chiama mola? È una ruota metaforica? Come faccio a chiudere la frase di prima, se non so con che tipo di oggetti interagisce questa ruota? Ce l’abbiamo una sigla? Lo so che non si usa ma non posso resistere: sigla!
L’idea di fondo di Darkest Dungeon è che fare l’avventuriero è una merda, e perché nessuno ne parla mai? Immaginate di essere non un eroe ma Gianluigi Spadaccino da Baranzate, esperto nell’arte dell’affettare cose con un pezzo di metallo, appassionato di birra e Gesù e lievemente claustrofobico; le vostre limitate capacità non sono spendibili in un contesto civile e vi tocca dunque arrabattarvi con lavoretti di fortuna che coinvolgano, appunto, cose da affettare (nell’attesa di trovarne uno che vi permetta di guadagnarvi da vivere bevendo birra e/o volendo bene a Gesù). State sorseggiando del piscio tiepido in una lurida taverna di Novate Milanese, perché questa sera vi sentite esotici, quando dal tavolo di fianco origliate una conversazione che vi fa drizzare le orecchie: c’è lo sciur Brambilla di Bollate che paga del gran cash a chiunque accetti di esplorare l’immenso sistema di sotterranei e altri luoghi della paura che si allargano sotto la tenuta della sua famiglia, i conti Brambilla.
Vi presentate a casa dello sciur Brambilla che vi allunga una spada mezza arrugginita e un cestino di pane raffermo e vi spedisce all’ingresso delle catacombe, dove fate la conoscenza di Lorenza Spaccaculi, Orlandone il Virtuoso e Gigina Del Veleno. Che bello! A caccia di mostri in compagnia!
Due ore dopo, siete stati morsi da insetti alti come cinghiali, mazzuolati da cinghiali in armatura alti come Shaquille O’Neal, avete finito il pane raffermo, Gigina ha ficcato le mani in una vergine di ferro e sanguina ininterrottamente da tre quarti d’ora, un maiale vi ha sputato del veleno in faccia, avete quasi finito le torce e non vedete più un cazzo, Orlandone ha incontrato l’abisso sotto forma di gigantesco verme con la faccia a Chtulhu e ora crede di essere un cereale, e tutto quello che avete avuto in cambio sono quattro spicci e questa stupida maglietta
Ecco, Darkest Dungeon è un generatore continuo di narrazioni di questo tipo, sospese tra l’unspeakable horror di lovecraftiana memoria, le piccole/grandi fatiche tipiche dei racconti di sopravvivenza e un certo gusto quasi comico per l’assurdo e il parossistico. La storia è quella di un tizio che eredita la tenuta di famiglia e i dungeon sottostanti e, al grido di “armiamoci e partite”, mette in piedi una squadra di avventurieri il cui compito è scendere sempre più giù negli abissi della Terra, fino ad arrivare al Darkest Dungeon che dà il titolo a tutto e che custodisce il segreto che bla bla bla scopritelo da soli.
Questa cosa succede a turni.
La grande forza di Darkest Dungeon è nel suo spostare costantemente il fuoco dal grande al piccolo e viceversa. Per metà del tempo è un gioco gestionale, anche piuttosto rigido, nel quale si clicca su dei bottoni per far comparire nuovi edifici e/o per investire denaro in [cose]. Più che la tenuta di famiglia, il villaggio di Darkest Dungeon è la Grande Fabbrica degli Avventurieri, dove si gestisce il roster, si scelgono i membri della spedizione successiva, ci si prende cura dei feriti e dei matti, si licenzia gente e se ne assume di nuova. Arriva poi il momento in cui tutto questo traccheggiare si fa inutile (Darkest Dungeon è un gioco di risorse, che vanno via come il pane e vanno costantemente recuperate) e, come prima di un’interrogazione a scuola, la mano dell’insegnante scorre letale su e giù sul registro. E vi giuro che non c’è nulla di sessuale, fino a che saltano fuori quattro nomi, quattro “volontari”.
Nessuno, in Darkest Dungeon, vuole andare a esplorare i dungeon.
L’anima del gioco è tutta nel rifiuto lovecraftiano di “tornare laggiù”. Voglio dire che i quattro selezionati hanno sempre qualcosa da dire, c’è chi chiede di essere risparmiato almeno a questo giro, chi invece si sente curiosamente ottimista: è il momento in cui Darkest Dungeon punta la lente sulle storie dei singoli, perché, per quanto sacrificabili e sostanzialmente intercambiabili (almeno all’inizio, perdere un personaggio che è sopravvissuto a decine di missioni è ovviamente una tragedia, è il classico gancio alla XCOM che funziona sempre, perché unisce emotività e gameplay in un’unica botta in faccia) i Nostri Non Eroi non sono tutti uguali.
È un altro dei piccoli colpi di genio del gioco di Red Hook: ogni nuovo personaggio arriva equipaggiato con il suo set di tratti caratteriali positivi o negativi, e altri ne potrebbe accumulare missione dopo missione, e ovviamente, essendo Darkest Dungeon un gioco di sistemi (ora ci arriviamo), un singolo tratto può rendere drasticamente più efficace (o inutile, e quindi sacrificabile) chi lo acquisisce. Per cui, sapere che Lullo Maghetto è un cleptomane con il terrore dei ragni non è solo colore, e dunque ignorabile, ma parte integrante del suo ruolo in una missione, o causa di licenziamento, anche.
I sistemi, dicevamo. Nel momento in cui abbandona le mura del villaggio per addentrarsi nei suddetti dungeon, Darkest Dungeon diventa un gioco di botte a turni, fortemente basato sul posizionamento dei personaggi (che stanno su un piano 2D schierati da sinistra a destra, specularmente ai cattivi di turno), sull’interazione tra abilità e sulla gestione e mitigazione dell’RNG. Entrare nei dettagli significa aprire un vaso di Pandora che nessuno di noi ha tempo e voglia di gestire in questa sede (immagino), ma dovessi indicare una e una sola delle mille idee brillanti che rendono il combattimento di Darkest Dungeon una roba complicatissima da imparare ma supremamente soddisfacente una volta fatto, direi questa: non esiste “l’attacco”. Quella roba che si fa nei JRPG quando si vuole far passare un turno e allora tanto vale dare una bottarella a un cattivo, per capirci. Ogni classe (ce ne sono 17, 15 + 2 incluse nei DLC) ha un set di ≈7 abilità, e ne può portare in battaglia solo quattro, che, con rare eccezioni, possono essere riutilizzate a piacimento (niente “cariche” o “cooldown”). Sostanzialmente, nessuna di queste abilità ha come effetto il semplicissimo “fai tot danni al nemico”. C’è sempre qualcosa, un twist, un’idea, un seme che, piantato all’inizio del combattimento, può germogliare tre, sei, dieci turni dopo e cambiare le sorti di questi quattro sfigati spediti a menarsi con dei funghi mannari, talmente sfigati che “stress” è un’effettiva statistica da gestire e tenere sotto controllo, perché se ti sfugge di mano, viene fuori un disastro, signora mia.
Il risultato è una rete fittissima di interazioni che, se gestite con criterio, possono non solo trasformare ogni combattimento in un balletto di schiaffi e morte che ti fa sentire per un breve istante il più figo del mondo, ma influenzare un’intera spedizione e salvarla dal disastro, se non proprio renderla un successo. E di spedizioni da salvare dal disastro ce ne sono a centinaia, in Darkest Dungeon: ognuna dura dai dieci minuti alla mezz’ora e ognuna riporta a casa giusto quanto basta per comprare uno o due upgrade, curare un paio di sfigati e poco più. Il loop è semplice e molto, molto ripetitivo, è anch’esso una ruota ma questa volta a finirci sotto è chi gioca, non i suoi poveri impiegati: il risultato potrebbe non fare per tutti, e sicuramente non fa per chi punta a finire rapidamente una partita e poi andare oltre. Perché non succederà: Darkest Dungeon è un gioco difficile e a tratti deprimente, e l’unico modo per tenere a bada la frustrazione è provare e riprovare fino a scoprire cosa funzioni in quali situazioni e perché.
Stando a quanto si legge in giro sull’Internet, Darkest Dungeon è un esempio classicissimo di gioco a cui moltissimi hanno giocato ma che pochissimi hanno finito – e che molti di quelli che non l’hanno finito annoverano comunque tra i giochi migliori a cui abbiano mai giocato. È comprensibile: gli ultimi dungeon sono massacranti e rischiano, con un paio di tiri di dado sbagliati, di mandare all’aria un certosino lavoro di preparazione dei personaggi durato ore; e non tutti hanno voglia di ricominciare sostanzialmente da capo, una volta che hanno visto il traguardo a portata di mano.
Non sono neanche sicuro che sia necessario vedere i titoli di coda, per venire colpiti e in qualche modo cambiati da Darkest Dungeon. Perché al di là del dettaglio e dei sistemi e dell’ingegneria e delle stat, il gioco di Red Hook è prima di tutto un simulatore di condizione umana in situazioni estreme, un template psicologico che si può applicare facilmente a qualsiasi personaggio di finzione sia mai stato sottoposto a stimoli tipo “un incontro con le creature tentacolari dell’altroverso”, come dimostrano le immagini a corredo del pezzo. È un po’ un “nessuno pensa ai bambini?” dove al posto dei bambini ci sono tutti quei poveracci che per anni abbiamo visto morire sotto i colpi delle spade dei non morti o delle zanne dei vampiri o degli artigli dei lupi mannari, un dito puntato contro il fordismo del fantasy che abusa della psiche di anonimi soldati in nome dello spettacolo e del nostro divertimento.
È anche su Switch, tra l’altro, così potete combattere contro gli orrori cosmici mentre cagate.
Questo articolo fa parte della Cover Story dedicata a Il trono di spade e al fantasy lercio, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.