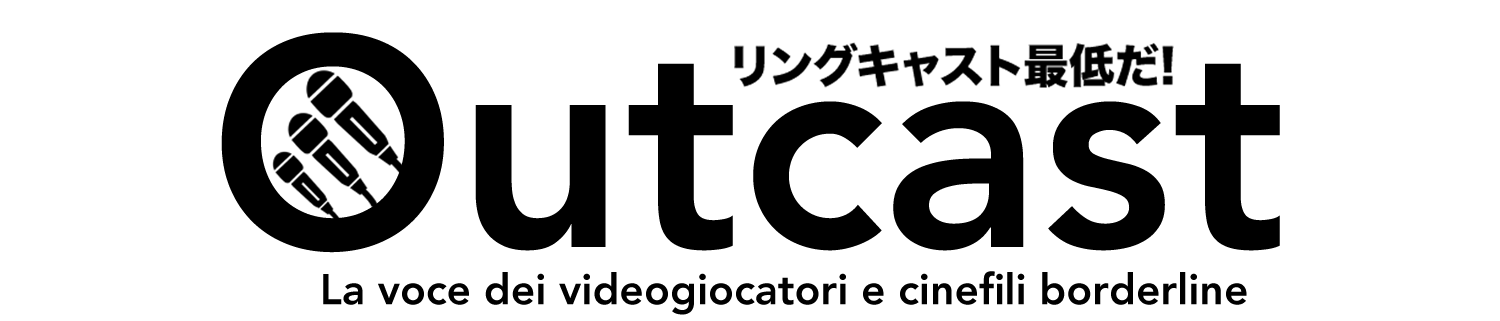E questa è la descrizione, la descrizione della mia morte. PRRRRRRRRRRRRRRRR
“Col cazzo che ci vado, in Mongolia!”
Come raccontavo l’altra volta, crepare mi fa una paura boia.
Oddio, immagino che la morte faccia paura a tutti, per carità. Però, come dire, solipsisticamente parlando, ho la sensazione che a me faccia più paura che agli altri.
Sono attaccato alla vita come una cozza al suo scoglio, e se avessi la possibilità di esprimere i classici tre desideri col genio e tutto il resto, sicuramente consumerei il primo per ottenere l’immortalità, e gli altri due per metterla al sicuro da ogni grana. Tanto per non fare la fine di Kars, l’avversario immortale del secondo (e tra tutti il più amato) JoJo, condannato a vagare nello spazio come un meteorite per tutta l'eternità.
Fare le cose a cazzo di Kars.
Dal momento che alla mente umana è negata l’astrazione della non-esistenza (no, sul serio, provateci), non ci è possibile gestire facilmente la morte, proprio come concetto. Probabilmente, a meno di non essere i boss di qualche multinazionale farmaceutica tecnologicamente avanzata - ché a quel punto uno le prova tutte - la cosa migliore è quella di non pensarci troppo, e di godere finché ci è dato.
Forse sono anche nato nel momento sbagliato, vai a sapere. In una recente intervista, Giovanni Lindo Ferretti osservava che, fino a qualche decennio fa, nei paesi contadini la morte non veniva evitata. Al contrario, veniva esposta in quanto parte inevitabile della vita, alla pari della nascita. I ragazzini venivano portati alle veglie funebri, messi faccia a faccia con i corpi dei propri cari; o a vedere la macellazione delle bestie, e in qualche modo finivano con l’abituarsi all’inevitabile. Oggi - sempre stando a Giovanni Lindo – si preferisce l’evitamento. Si cerca di gestire la morte nella maniera più asettica e pulita possibile, con la conseguenza di allontanarla dalla sfera del reale.
Che ha anche senso, fermo restando che dopo un po’ faccio fatica a stare dietro a Ferretti: sono molto più in sintonia con la filosofia di vita del suo chitarrista storico, Giorgio Canali, che detesta la natura, ama le serie TV, e in generale non alloggia mai troppo distante da un tabaccaio.
Anche la narrativa che ci riflette, spinge forte sull’accettazione della morte.
In genere, i cattivi cercano di dribblare il trapasso a ogni costo, magari inseguendo l’immortalità; mentre gli eroi ci convivono, e se serve si sacrificano pure. Quasi sempre, nei racconti, per acciuffare la vita eterna bisogna pagare un pegno di sangue o rinunciare alla propria umanità (prendi i vampiri, toh).
Mai una volta che la via per l’immortalità sia costellata da buone azioni. Tipo (patto Soros): salvi mille gattini e vivi per sempre. No, stocazzo. Al massimo, dopo aver salvato i cuccioli, finisci in paradiso, o ti cucchi l’immortalità dell’anima (figurarsi), tanto per stare sul vago. E invece uno, senza troppi sofismi, magari vorrebbe solo tirare avanti per sempre col suo tran-tran terreno, tutto qua.
Se lo chiedete a me, da un lato non posso che subire il fascino di una certa epica eroica, ma a mentre fredda faccio quasi sempre il tifo per gente come Voldemort, Orochimaru o Walter Donovan. Gente che non molla.
Oh, a me, per stare in questi paraggi andrebbe bene tutto, pure farmi il viaggio del vampiro (vampiri che leggete Outcast, contattatemi in pm). Tenete conto che, solo qualche giorno fa, commentando con giopep il nuovo trailer di Venom, ho candidamente ammesso che non mi troverei male nemmeno con un simbionte tra le balle. Vedi te.
Comunque, per via di questa mia fisima, le morti simulate dei contesti ludici mi hanno sempre fatto sentire a disagio. Quando da ragazzino giocavo a palla avvelenata, e finivo – appunto – per essere avvelenato, mi pareva che un pezzetto di anima si staccasse dal mio corpo. Mentre durante le partite a “Ce l’hai”, quando ce l’avevo, mi immaginavo un timer sopra la testa come in un episodio di Ken il guerriero.
Mi ha detto mio cuggino che sa un colpo segreto che se te lo dà dopo tre giorni muori.
Le cose non sono migliorate con i videogiochi. Anzi. Se possibile all’inizio sono addirittura peggiorate. I primi coin-op erano completamente proni rispetto al loro modello di business: i gettoni. I titoli ospitati dai cabinati erano perlopiù basati su dinamiche “trial & error” e avevano grossomodo due scopi principali a cui venivano subordinate tutte le altre variabili di design: interrompere di tanto in tanto l’afflusso di adrenalina al cervello e farti inserire un’altra moneta.
Il discorso è trito e ritrito, mi rendo conto. Eppure non dimenticherò mai quel particolare senso di vuoto, di leggerissimo mancamento, che saltava fuori quando il biondino di Wonder Boy andava a sbattere contro una lumaca, o quando Mario piombava nel vuoto. Tu sei lì, tutto concentrato. La tua mente ha già disegnato perfettamente la traiettoria e ti aspetta più avanti di qualche pixel. Ma il corpo non è in pari e... bum! Morto.
Quando ci restavo secco nei videogame degli anni Ottanta e Novanta provavo un fastidio fisico, probabilmente figlio di questa momentanea idiosincrasia tra mente e corpo. Ché poi è anche un bel modo di metterla in metafora: l’anima che per qualche secondo se ne va fuori sincro.
Tra l’altro, quella sensazione di sconfitta così netta me la procuravano più che altro i platform in dueddì. Già con i picchiaduro era diverso: ti logoravano, ti indebolivano, ti frollavano. L’ansia era persistente, ma non da tuffo al cuore. Se penso al baratro di Super Mario Bros. penso a un proiettile, mentre le barre di energia di Cadillacs and Dinosaurs o di Street Fighter II sono più simili a un gommone bucato mandato alla deriva.
Non è una perfetta e semplice immagine della vita e della morte?!?
Con gli anni, le cose sono cambiate. Soprattutto, con la fruizione casalinga è cambiato il modello di business dei videogiochi, sono cambiate le meccaniche. Sono nati nuovi generi parzialmente o del tutto emancipati dal concetto di morte o di game over; vincolati a fonti di gratificazione sempre meno “chimiche”. In certi casi, le ricompense si sono spostate dai punteggi alla narrazione (avventure grafiche, giochi di ruolo), in altri in zone al limite della contemplazione (SimCity). Si è creato spazio per giochi come The Sims o i vari Animal Crossing, dove parte del piacere deriva dal possesso di oggetti e beni virtuali, o addirittura dalla semplice esistenza digitale.
Quando arriva, arriva.
E la morte? Lasciando perdere i decessi legati alle esigenze narrative (Final Fantasy VII), tra checkpoint e salvataggi automatici, si è trasformata in una specie di benigno teletrasporto. Da schiaffo a buffetto. Il che, intendiamoci, sotto parecchi punti di vista è un bene: diversamente, oggi non staremmo giocando - tipo - al 90% delle robe che ci piacciono. Tuttavia, il rischio di ripescare qualche checkpoint o riprendere dall’ultimo salvataggio offre un brivido relativo, rimediato. La morte virtuale – in virtù di una “simulazione nella simulazione” - è separata dalla realtà da un ulteriore livello ermeneutico, e conseguentemente la disfatta pesa meno.
Invece, crepare nel bel mezzo di una sezione a Ghouls 'n Ghosts, in sala giochi o al bar, oltre al trapasso economico, ne procurava pure uno temporale: “Per oggi ho finito i soldi/non potrò tornare a giocarci fino al prossimo weekend, o addirittura alla prossima estate”. In questo senso, le macchine da gioco domestiche o portatili hanno ridotto - se non azzerato - i vincoli di accesso ai titoli arcade.
Detto questo, ripeto, non sono qua a condannare ovvie comodità come checkpoint, salvataggi e palle varie, che tra l’altro hanno permesso a un sacco di gente di avvicinarsi ai videogiochi con più serenità. Al giorno d’oggi, blockbuster come i vari Assassin’s Creed sono sufficientemente flessibili da adattarsi al giocatore che hanno davanti. Per non parlare dei drammi interattivi come Virginia o Gone Home, fruibili praticamente da chiunque (se poi “chiunque” effettivamente finisca col fruirne, è un altro discorso).
Dovunque andassi e qualsiasi cosa facessi, ero sempre in cerca del posto perfetto dove sospendere il mio filo.
Eppure, forse come reazione ai “giochi facili” o forse solo perché gli girava così, diversi studi hanno scelto di imboccare la via del martirio.
Piano piano, radicalizzando sempre di più il concetto di “trial & error”, alcuni autori hanno imparato ad adoperare la morte come vero e proprio elemento di design, anziché come punizione. Giochi “masocore” come VVVVV, Super Meat Boy, Limbo, Inside (oddio, più Limbo che Inside, ma forse ricordo male) e Cuphead sono praticamente impossibili da portare a termine senza accumulare un certo numero di decessi. Stesso discorso, se non peggio, per i cosiddetti “soulslike”, come i tre Dark Souls (appunto) o Bloodborne.
Diversamente dai titoli arcade del passato, dove attraverso la pratica era possibile maturare le skill necessarie per avanzare di parecchie spanne senza necessariamente crepare ogni due secondi, nei soulslike e simili la morte è indispensabile per imparare a leggere l’azione o per mappare l’area di gioco. Spesso, trabocchetti mortali e avversari pressoché invincibili si manifestano a tradimento, e l’unico modo per sopravvivere è quello di far “scattare la trappola” almeno una volta.
Personalmente, non sono un fan della prestazione e sono arrivato davanti a Bloodborne vergine dei primi soulslike. Ero prevenuto, pressoché certo che un gioco del genere non avrebbe fatto per me.
E invece, saranno stati la mitologia, le spintarelle degli amici o le atmosfere alla Lovecraft, una volta tanto ho tenuto duro. All’inizio sono morto un casino di volte, ovviamente. Poi ho compreso che nei soulslike il primo ricettacolo dei potenziamenti non è l’avatar, ma il giocatore. Nessuna morte è inutile, nessuna ripetizione va sprecata in termini di esperienza. Tutto fa massa.
E una volta superata la barriera di ingresso, dopo aver scollinato, ho finito con l’amare le finezze di Bloodborne, la sua grande correttezza nella severità. Sono entrato in sintonia con l’incredibile world design di Hidetaka Miyazaki, sono diventato un videogiocatore migliore. Ma soprattutto ho imparato a morire. Ed è stato bellissimo.
Questo articolo fa parte della Cover Story “Ricordati che devi morire”, che potete trovare riassunta a questo indirizzo.
Come al solito, se acquistate i film segnalati nel pezzo (o qualsiasi altra cosa) su Amazon passando dai seguenti link, una piccola percentuale di quello che spendete andrà a noi, senza alcun sovrapprezzo per voi. Se volete procedere su Amazon Italia dirigetevi qui, se preferite Amazon UK puntate qui.