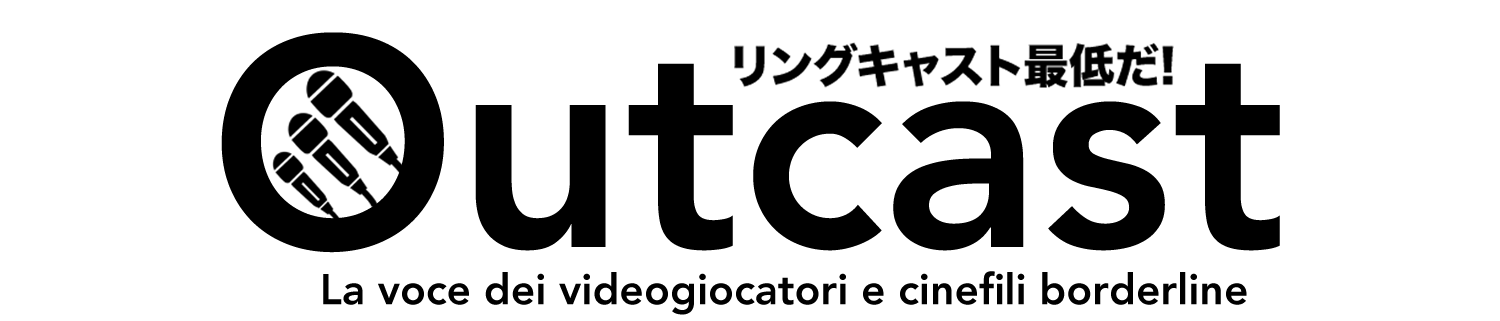LVDGRB - La vita di Gipi raccontata bene (da lui)
“«Quando arriviamo a casa di Gipi comportati bene e, se lo adoperi, lascia il bagno pulito.» ”
Viaggiare in mia compagnia è un autentico incubo: detesto muovermi da casa e le poche volte che lo faccio, rompo continuamente le palle, lamentandomi in continuazione. Sono pieno di fissazioni, odio le partenze mattutine e, in linea di massima, sono sempre più contento quando ritorno di quando parto. Ah, sono anche un pessimo ospite: maleducato e ingrato nel migliore dei casi.
Nonostante queste tare brutte, ho ancora amici che mi sopportano e uno di questi, un paio di settimane fa, ha deciso di spostarmi per un weekend da Como fino Roma, di ospitarmi nella sua casetta in zona Vaticano (taac!) e - nonostante dopo poche ore in mia compagnia fosse già piuttosto esasperato - di portarmi con sé a casa di Gipi, con la missione di fare autenticare dei bellissimi artwork dedicati a Destiny, realizzati dal nostro su commissione di Activision per l’area “Spazio” del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, dove sono tutt’ora esposti al pubblico.
Di fresca e assolata mattina ci imbarchiamo sulla metro e procediamo fino una delle ultime fermata della linea B, dove veniamo raccolti dalla moglie di Gipi, che ci accompagna in auto fino a casa loro, attraverso un percorso verdissimo, che ci affranca con un certo sollievo dalla monnezza e dalla fumera nera che in quei giorni affliggono la Capitale.
Al cancello veniamo accolti da un paio di festosi cagnoloni e, a seguire, da Gian Alfonso Pacinotti in persona, che ci apre con cortesia, ci invita ad entrare e ci prepara pure un caffè, davanti al quale attacchiamo a chiacchierare di videogiochi e di realtà virtuale (adora entrambe le cose), ma anche e soprattutto di fumetti. Gipi accetta di ingaggiare una lunga intervista per Outcast e di raccontarmi un po’ della sua poetica e del suo lavoro, soffermandosi soprattutto sul suo ultimo libro, La terra dei figli, che considera sia un punto di arrivo che un grosso punto di rottura rispetto alle opere precedenti, vuoi perché abbandona il taglio autobiografico de La mia vita disegnata male o S., vuoi per l’approdo a un linguaggio più netto ed economico, soprattutto sul piano dialogico.
Tra una cosa e l’altra, la chiacchierata è andata avanti per quasi due ore, mentre la mattinata si scioglieva via nell’atmosfera serena di quella bella casetta in collina. E a ripensarci, è stato proprio strano condurre un’intervista del genere in una situazione del genere, con calma e senza fracasso.
Alla fine, quando Gipi ha dovuto congedarsi per mettersi al lavoro e la moglie ci ha riaccompagnato alla stazione della metro, mah, ero un po’ meno contento del solito di tornarmene a casa, dai.
Di seguito trovate la trascrizione di tutta la chiacchierata, con pochissime intromissioni e pressoché intatta, comprese certe “c” pisane al posto delle mie brutte “g” da lombardo. Buona lettura.
Andrea Peduzzi: Ne La terra dei figli ti confronti con diverse tematiche, ma soprattutto con i riti di passaggio verso l’età adulta, il concetto di lascito e la paternità. Durante gli ultimi anni, questo motivo mi è arrivato piuttosto spesso, attraverso storie provenienti dal cinema, dalla letteratura e persino dai videogiochi (The Last of Us). Pensi che l’attuale diffusione di questo tipo di storie sia dovuta a ragioni “anagrafiche”, cicliche, legate all’età di una certa generazione di artisti e autori, o ci vedi motivazioni più profonde, ambientali o sociali? Cosa spinge un autore a sfogare il tema della paternità sul piano artistico?
Gipi: Se guardo ai libri che ho fatto finora ci vedo tutta una serie di ossessioni cicliche, e il rapporto con i padri è senz’altro una di queste. Mio padre non aveva niente del padre de La terra dei figli, a parte forse l’aspetto fisico, ma la sua morte mi ha lasciato in sospeso un sacco di domande che immagino non avranno mai una risposta, le stesse domande che hanno finito col diventare, piano piano, delle piccole ossessioni; e come ho detto, io traduco sempre - volente o nolente - le ossessioni che ho per la testa nelle mie storie.
Con La terra dei figli ho fatto una cosa che prima non avevo mai fatto: ho assunto un punto di vista genitoriale. Nei miei precedenti racconti mi sono sempre sentito un “figlio”, e la voce narrante era conseguentemente una figura che non aveva famiglia, che aveva abbandonato la famiglia, o che aveva un conflitto in corso con la famiglia. Questa volta, invece, forse per una questione puramente anagrafica, mi sono sentito più prossimo alla figura del padre, fermo restando che io di figli non ne ho, e non credo ne avrò mai, quindi mi sono limitato ad architettare una simulazione. Non ho idea di cosa significhi veramente essere padre.
Tornando alla domanda, non saprei dire se la diffusione di un certo motivo dipenda da questioni generazionali o sociali, ma si tratta di un tipo di problema che non mi pongo mai. D’altro canto è pur vero che quando un narratore si confronta con una storia, a meno che non sia completamente scollato dall’esistenza, tende a assorbire come una spugna tutto ciò che lo circonda, e se il vento soffia in una certa direzione, volente o nolente ci finisce dentro.
Ne La terra dei figli desideravo principalmente comunicare il sacrificio d’amore che affronta il padre. Mi spiego meglio: in genere i padri, o i nonni, sostengono che il loro mondo era migliore. Se ripenso alla mia adolescenza, io a quindici anni volevo solamente suonare con la mia band hardcore dalla mattina alla sera, e ricordo che mio padre - che trovava la cosa inconcepibile - mi definiva un “tdc” (non voglio censurarmi, è che me lo diceva talmente tante volte che aveva trovato l’acronimo). In realtà quello che succede è molto semplice: quando si invecchia, e io questa cosa oggi la sto provando sulla mia pelle, non ci si capisce più niente del mondo che ci sta attorno. Magari vai alle fiere del fumetto e trovi folle oceaniche di ragazzi che sono lì solo per gli YouTuber, e non te ne capaciti; ma non è perché il mondo si è rincoglionito, è perché tu ti sei rincoglionito. A quel punto puoi fare due cose; puoi criticare i giovani, oppure puoi fare quello che fa il padre de La terra dei figli: negarti il piacere della nostalgia saccente e lasciare che siano perfetti per il mondo in cui vivono. Perché loro saranno perfetti, per quel mondo. Sei tu che non li capirai.
La cosa buffa è che ne La terra dei figli il padre, a differenza dei nostri contemporanei, avrebbe tutte le ragioni oggettive per dire «ai miei tempi era meglio», ed è proprio questo che fa di lui un eroe, perché quello della sua infanzia era un mondo tutto sommato vivibile, dove non ci si ammazzava così a buffo, dove si poteva andare al supermercato a fare la spesa e preparare la pastasciutta a casa. Lui rinuncia a tutto solo per far sì che i suoi figli non abbiano mai nostalgia di niente e siano perfetti per il mondo che li attende. Trovo che quello sia un gesto d’amore molto forte e io questa cosa, che il libro parlava d’amore, sulle prime non l’avevo capita sulle prime. Durante la lavorazione, dopo trenta trenta pagine, ho sentito il bisogno di fermarmi perché non riuscivo a definire a sufficienza quello che avevo davanti. Ho messo il lavoro in stop per un anno, durante il quale ho fatto altro, ma sempre interrogandomi sulla natura del libro in corso. Quando ho capito che parlava d’amore, il finale si è scritto praticamente da sé.
Andrea Peduzzi: Ho notato che nelle tue opere i padri sono spesso figure severe, dure, inflessibili, e che in qualche modo designano i loro eredi per affinità. Penso al rapporto tra Felix e Killer in Appunti per una storia di guerra, a quello tra il pirata e il poeta de LMVDM, o più prosaicamente a quello genitore-figlio de Questa è la stanza. Sembra quasi che i genitori scelgano di allontanare i figli dal rischio dell’amore, per proteggerli. Perché?
Gipi: Nelle storie precedenti a La terra dei figli, raccontavo sempre di un’allontanamento dalla famiglia, cosa che rispecchia la mia esperienza giovanile.
Da ragazzo ero piuttosto difficile, inquieto, e molto presto ho abbandonato la famiglia preferendole il mio gruppo di amici, che piano piano hanno finito col diventare i miei fratelli, i miei cugini, i miei zii e tutto quanto. Ho sempre cercato figure di riferimento alternative a quella di mio padre, e non necessariamente in persone più anziane di me o migliori di me.
Poi, quando ho cominciato a invecchiare, mi sono accorto che mi stavo trasformando piano piano in mio padre, e nel farlo sono riuscito a comprendere tutto l’amore che lui cercava di darmi, a modo suo. Sorprendentemente, oggi trovo gradevole la sensazione di assomigliare a mio padre; mi piace l’idea di diventare come lui.
Mio padre è del 1922, ha avuto i suoi vent’anni quando in Italia c’erano i nazisti e fascisti e mi ha raccontato delle storie di una tale intensità sulla sua giovinezza, di una tale vita… Lui non era affatto fascista, ha avuto le SS alle costole, si è confrontato con le mitragliatrici. Mio padre, da ragazzo, ha potuto confrontarsi col rischio della morte, ha potuto mettere alla prova la sua forza d’animo, la sua generosità, la sua abnegazione verso gli altri. Io invece ho vissuto la mia giovinezza a ridosso del boom economico, in una situazione di comodo che non mi avrebbe lasciato molte occasioni per conoscere la mia pasta, se non avessi scelto di schivarla.
Mio padre e mia madre erano persone benestanti, la nostra era una famiglia di buona borghesia pisana e a casa non ci mancava nulla: andavamo a fare le vacanze sulla neve, avevamo la casa al mare, etc. Tutta roba che da ragazzo detestavo, perché mi faceva da guscio di protezione, e che sentivo mi avrebbe impedito di comprendere che tipo di uomo fossi. Così, non appena ho potuto, mi sono allontanato da casa, e di conseguenza anche nelle mie storie la dimensione genitoriale è stata a lungo una dimensione di allontanamento. Di abbandono e di ricostruzione di figure di riferimento alternative. Ho finito per costruirmi inconsciamente un’ambiente che fosse il più inospitale possibile, per poter testare la mia qualità umana, e da quei test, anni dopo, sono nati i miei primi libri.
Più in generale, io penso che gli adolescenti dovrebbero poter vivere in un sorta di giungla, poter affrontare un rito di passaggio verso l’età adulta; un rito qualificato, riconosciuto, ma che nel mondo di oggi viene completamente negato. Oggi le persone sono spinte a rimanere degli eterni adolescenti. Intendiamoci, penso che il benessere sia una cosa ottima, spero che duri il più a lungo possibile, ma il fatto che oggi gente di trentacinque o quarant’anni abbia la casa come quella di un ragazzino, con le action figure di Star Wars e tutto il resto, e senta di sottofondo un rimando continuo a diventare un vero adulto, responsabile (cosa che io vivo al cento per cento, intendiamoci), non mi suona proprio benissimo. C’è una sorta di “coccola generalizzata” che poi, spesso, stride in modo tremendo con le condizioni economiche reali: vieni spinto a essere un ragazzino per sempre, e allo stesso tempo magari, non hai da lavorare.
Tra l’altro, se ragazzino lo sei davvero – anagraficamente - è probabile che il lavoro te lo aspetti. Ti aspetti che le cose ti vengano date, non che tu te le debba prendere “facendo fuori” quelli che sono venuti prima di te (metaforicamente, beninteso: sul piano della qualità del lavoro, della sensibilità, della competenza). Io sono un fumettista, non certo un sociologo, e sono pure un ignorante tremendo, però nel piccolo della mia sfera professionale noto che molti giovani si aspettano il diritto a essere fumettisti. E questo lo trovo pazzesco, perché a conti fatti stanno chiedendo una posizione di privilegio che consentirebbe loro di campare del lavoro che amano, magari in situazioni di grande libertà operativa, e se va ancora meglio, con gli occhi dolci delle ragazzine alle fiere. E tutto questo non lo vorresti pagare? Io, da ragazzino, sapevo che per avere una posizione privilegiata dovevo pagare, farmi il culo, stare chiuso in casa per ore, giorni, a disegnare, lasciarci due vertebre della spina dorsale e compagnia bella.
Andrea Peduzzi: Hai parlato di prezzo, di pagamento. Ma oltre al sangue versato sull’altare della tecnica, pensi che anche le tue esperienze di vita, la ricerca di ambienti inospitali e tutto il resto, siano state un prezzo pagato alla poetica?
Gipi: Sì, penso di sì. Oddio, non che lo avessi pianificato, ma da che mi ricordo ho sempre desiderato raccontare le avventure più estreme che vivevo con i ragazzi della mia gang. Il problema è che all’epoca non avevo proprio idea di come fare. Certe storie mi parevano meravigliose da raccontare, ma anche formalmente irraccontabili: per me, cresciuto con un’immaginario estetico a metà tra i supereroi e il fantasy, era impossibile concepire l’idea di descrivere la vita di cinque ragazzini che si ritrovavano a fare scemenze tra le panchine di un giardinetto pubblico. Nessuno di noi aveva superpoteri, non avevamo una donna nemmeno a pagarla oro, facevamo cacare a vederci. Soprattutto, vivevamo in un posto che non sapeva di nulla, era brutto. Le macchine erano brutte, i palazzi erano brutti. Dal mio punto di vista non c’era niente di eccezionale da raccontare, non c’era epica.
Ho scritto e disegnato il primo libro a trentasette anni, anziché a venti, proprio perché ho fatto fatica a trovare un linguaggio adeguato al mio immaginario. A non farmi gettare la spugna per tutto quel tempo sono state due cose: una sorta di “fascinazione per la forza” (tutti i miei amici erano migliori di me, più coraggiosi di me, più estremi di me, più pazzi di me) e i sensi di colpa. Della mia gang, io ero l’unico a provenire da una famiglia agiata, ero l’unico che, se fosse cascato per davvero, sarebbe atterrato sul morbido, su una base d’amore (per quanto abbia cacato il cazzo a mio padre e a mia madre in tutti i modi possibili). Alcuni dei miei amici storici, quando sono cascati, si sono fatti male per davvero
In Appunti per una storia di guerra racconto proprio di questo: di un ragazzino che scappa assieme a due poveracci con l’unico desiderio di essere considerato un loro pari. E questo non avverrà mai, così come i ragazzi con cui sono cresciuto non hanno mai considerato me, un loro pari.
Andrea Peduzzi: In effetti, un altro tema che mi è arrivato forte leggendo i tuoi lavori è proprio quello del senso di colpa. Ne La mia vita disegnata male emerge nei confronti di un tuo vecchio amico d’infanzia; lo stesso senso di colpa viene trattato, come hai appena osservato, anche in Appunti per una storia di guerra. È come se i tuoi personaggi, nonostante vivano a tratti nella disperazione, sentano una sorta di disagio verso chi è ancora più disperato di loro. Come mai?
Gipi: Se ci fai caso, i narratori delle mie storie non sono mai dei disperati autentici, ma sono sempre “un paio di occhi”. Soprattutto prima de La terra dei figli, i miei protagonisti non erano mai eroi, non agivano, non determinavano mai con le loro azioni il corso della storia. Il personaggio principale di Appunti per una storia di guerra, ad esempio, non fa nulla, non agisce. Percorre un sentiero di cambiamento, OK, ma solo attraverso l’azione dei suoi compagni. Lui, semplicemente, li segue osservandoli, che poi è esattamente quello che ho fatto io con i miei amici. C’è un motivo per cui io sono qua a raccontare le storie della mia giovinezza, a fare il furbo con i libri in uscita, mentre i ragazzi della mia gang hanno vissuto dei momenti duri; il motivo è che io, anziché stare davvero al loro passo, li guardavo. E per poter guardare gli altri devi stare per forza più indietro. Se all’epoca mi fossi trovato davvero sulla line del fuoco, oggi non sarei qua a raccontarlo. Questa mia curiosità, unita al desiderio di raccontare e, soprattutto, a una brava mancanza di coraggio, mi ha impedito di cadere a terra.
Andrea Peduzzi: Ne La terra dei figli ho avuto la sensazione che il tema della paternità a un certo punto si intrecci anche con quello della religione. Il padre diventa quasi il sacerdote involontario di un culto, e nulla vieta di immaginare che, con lo scorrere del tempo e delle generazioni, potrebbe trasformarsi agli occhi dei fedeli addirittura in un “dio”. Ci ho visto giusto?
Gipi: Tutta la faccenda del padre e del suo “libro dei fedeli” mi è proprio nata tra le mani in corso d’opera, quasi per caso. Anche la figura del Boia, che nella scrittura originale doveva comparire solo in un breve passaggio, ha finito con l’aumentare di importanza nella stesura originale. All’inizio, doveva essere un personaggio malvagio che si elevava attraverso il quaderno del padre, salvava i ragazzini da morte certa per poi, semplicemente, uscire di scena.
Quando ho iniziato a impostarlo sul piano grafico, però, ho finito per affezionarmici, con quella sua maschera da sub e tutto il resto. Mi sono detto: «Cazzo, ora che sei diventato buono, non ti posso abbandonare così», e l’ho fatto diventare una figura di riferimento per i fedeli. Sentivo che il personaggio aveva acquisito una forza non prevista e che gli dovevo qualcosa di più che una semplice dissolvenza.
Io per natura sono un pessimista/ottimista: credo che il mondo migliori sempre, ma che nel mentre capitino degli sfaceli terrificanti, come una specie di grafico in salita costante, salvo dei picchi in discesa qua e là. Così, ho pensato che dovevo dare una speranza anche a quelle bestie immonde che erano i fedeli; per me nel quaderno c’è amore puro, e ho pensato che la trasmissione di quel tipo di amore avrebbe potuto cambiare i cuori di quegli esseri apparentemente senza speranza.
Andrea Peduzzi: Ne La terra dei figli, le tematiche del lascito e del passaggio generazionale non sono iscritte nel normale scorrere del tempo, ma vengono gestite in modo assoluto, iperbolico. Si intrecciano addirittura a un apocalisse e a una rigenerazione: perché? Per te l’apocalisse è una punizione, un’occasione, o magari entrambe le cose?
Gipi: Credo che tutte le mutazioni siano occasioni. L’apocalisse che racconto ne La terra dei figli è senz’altro un dramma per quelli che hanno conosciuto il mondo precedente, ma rappresenta l’unica realtà per i giovani protagonisti.
Come ho già detto, penso che ogni passaggio generazionale escluda inevitabilmente alcune persone e apra al contempo delle porte per altre. In genere i giovani abbracciano il cambiamento, mentre i vecchi si sentono tagliati fuori.
Va anche detto che durante l’ideazione del libro non ho fatto grossi ragionamenti, e all’inizio cercavo solamente di rappresentare l’isolamento dei personaggi, una situazione che consentisse ai due ragazzini di essere liberi come animali; liberi da ogni convenzione, liberi da sé stessi, come professa Kurtz in Apocalipse Now.
Andrea Peduzzi: Partendo da questo spunto, per te la natura delle cose è involontaria o soggetta ad arbitrio? Lo dico perché dalle tue opere sembra emergere una dimensione naturale che non si cura dell’uomo, e che sembra condividere il punto di vista di Herzog espresso attraverso Grizzly Man. Questa visione è corretta?
Gipi: Conosco Grizzly man, e sono d’accordo con Herzog. In linea generale, credo di essere una delle persone meno antropocentriche che esistano; per me gli uomini sono “caccole sulla terra”, un battito di ciglia, eppure sono convinti di essere i padroni del mondo, di costituire la società definitiva.
Penso che non sia così, penso che verrà un giorno in cui noi uomini non ci saremo più, mentre tutto il resto continuerà ad esistere. Non lo dico né da animalista né tantomeno da nichilista, tendo semmai a vedere l’insieme delle cose come una musica in cui l’umanità è entrata come una serie di accordi, e come una serie di accordi se ne uscirà. Questo senso di precarietà finisco con l’applicarlo un po’ a tutto. Ad esempio lo applico al tema dell’immigrazione: ci sono persone che difendono la propria tradizione, la propria patria, ma guardando le cose in prospettiva, non esistono nessuna tradizione e nessuna patria. Il respiro delle ere geologiche ci rende minuscoli. Eppure, c’è una tale quantità di infinito sia nel grande che nel minuscolo, che la faccenda in sé non è poi così drammatica.
Pensa che io, una volta, mi sono messo un telescopio in giardino, e dopo lunghe ricerche (ero pur sempre un “astronomo” di scarso livello) trovo Saturno: ai miei occhi è una pallina bianca con un anellino intorno, ma mi fa commuovere. Decido di andare in cucina, incrocio una mosca morta, le strappo un’ala, la metto su un microscopio, inizio a fare la spola tra giardino e cucina per passare da una dimensione all’altra, e di colpo mi prende una vertigine pazzesca, come se mi trovassi in equilibrio su un filo teso tra due infiniti, e questa cosa mi ha tolto il fiato. È molto difficile pensare di ammazzare un’altra persona dopo che hai percepito una sensazione del genere, perché annulla ogni idea di stato, di provincia di regione di nazionalità, di razza. Ti leva tutto, ma te lo leva in un senso buono.
Andrea Peduzzi: Guardando al tuo percorso di autore, mi è parso di notare un progressivo lavoro di sottrazione sul linguaggio in direzione di una certa purezza espressiva. Secondo te, qual è la forma di fumetto più netta (non necessariamente la più efficace o efficiente)?
Gipi: Posso parlare solo del mio lavoro, perché non ho né la presunzione né le competenze per poter giudicare quello degli altri. In quest’ottica non assoluta, la forma di fumetto più pura che ho esplorato finora è quella de La terra dei figli, perché sono riuscito ad agganciare emotivamente il lettore attraverso parole e personaggi, in maniera diretta, senza ricorrere a nessun tipo di meccanismo o di trappola. Nei miei libri precedenti, la commozione, quando c’era, era sempre figlia di un meccanismo strutturato. Sapevo per esperienza che accostando un certo tipo di scrittura a un certo tipo di disegno e di pittura riuscivo ad aprirmi una fessura nei lettori per far penetrare più in profondità le mie parole. Le medesime parole e i medesimi disegni che, magari, presi singolarmente non avrebbero avuto lo stesso effetto. Lavorando a La terra dei figli, ho capito quanto mi avesse stufato quel modo di raccontare, così sono tornato al cuore della narrazione: ho tolto di mezzo il narratore, spostando le attenzioni del lettore verso i personaggi.
Quello che mi fa essere fiero di questo libro (non sono mai stato veramente fiero dei miei libri: voglio bene a tutti, ma non li ho mai finiti con l’idea di aver fatto una cosa “giusta”) è proprio il fatto che sono riuscito a levarmi di torno. Arrivato a una certa età, e dopo aver collezionato tutta una serie di esperienze, ho deciso di smettere di chiedere l’amore al lettore e di sperimentare una storia “alla vecchia”.
Per anni mi sono dato in pasto alle persone, ma oggi, con i social network, è una cosa che fanno tutti, tutti i giorni. E io vengo pagato per il lavoro che faccio, e devo necessariamente andare in un’altra direzione per meritarmi la paga.
L’autobiografia ha una dimensione dittatoriale che non lascia nessuna libertà interpretativa al lettore, ma solo una scelta di affezione: «voglio bene alla persona che mi racconta questi fatti, oppure no?». L’autobiografia non è sindacabile, e quando me ne sono accorto ho provato vergogna, perché per me la libertà rappresenta un valore. Anzi, forse è l’unico valore che apprezzo. La libertà assoluta. E cazzo, imposto la mia vita sulla libertà assoluta, e poi nei libri finisco per negarla ai lettori? Non mi tornava più, ‘sta roba, quindi ho deciso di lavorare a qualcosa che desse ai fruitori la possibilità di scegliere per quale personaggio parteggiare, di immaginare, di sperare, di giudicare. Eppure, a metà del lavoro, quando ho capito che stavo delegando la possibilità di giudizio, ho avuto un attacco di panico: i lettori non potevano sindacare su S. o su La Mia Vita Disegnata Male: in quel genere di narrazione l’autore è un dio in senso assoluto. Ne La terra dei figli, invece, posso decidere se c’è il sole o se piove, se uno vive o muore, ma è un potere sindacabile da parte del lettore. Passare a quel genere di narrazione è stata dura, ma era inevitabile che cambiassi registro: quando insisto troppo sui medesimi schemi non mi piaccio per niente.
Andrea Peduzzi: Sempre restando sul linguaggio: ti interessa o ti affascina l’idea di un fumetto capace di esprimersi solo attraverso segno e azione, senza dialoghi, oppure non è una roba nelle tue corde?
Gipi: Non lo so. Tempo fa avevo iniziato a lavorare su una storia completamente muta, ma dopo averne realizzato diciassette tavole ho capito che mi stava dando qualche problema: da un lato non penso che i miei disegni abbiano la potenza necessaria per reggere sulle spalle il peso di tutta una storia; dall’altro, scrivere semplicemente mi piace troppo. Mi piacciono le parole, mi piace il ritmo che danno al racconto. Per me, rinunciare alle parole non è come levare il testo da una canzone, ma è più come levarci la batteria. Ne ho tolte tante, di parole, ne La terra dei figli, e ne toglierò anche alla storia a cui sto lavorando, che per ora è solo scritta; ma non penso di poterne fare completamente a meno.
Andrea Peduzzi: Hai lavorato su un gioco di carte, Bruti: come ti sei trovato nel passaggio tra un linguaggio per certi versi legato al mito, quello dei fumetti, e uno che deve invece qualcosina di più al rito? Al di là del segno, quanto c’è della tua poetica e delle tue meccaniche narrative nel gioco? Hai attinto a qualcosa in particolare?
Gipi: Non ho attinto a nulla, nel senso che Bruti l’ho fatto – non trovo un modo più sensato per metterla giù – a cazzo di cane. Ho sempre avuto la passione per i giochi, e un bel giorno mi sono inventato questo, l’ho provato assieme degli amici, ho visto che si divertivano e ho deciso di portarlo avanti. Certo, farlo diventare una cosa “vera” è stata dura, ho commesso tanti errori, ma alla fine sono stato ripagato da un sacco di affetto e di partecipazione da parte dei giocatori.
Di mio, inteso della mia poetica e del mio modo di raccontare, nel gioco ci sono proprio le meccaniche, che sono state studiate per generare racconti di combattimento. Per me la soddisfazione più grossa è vedere i giocatori di Bruti che, magari, dopo una partita si raccontano la partita stessa, come se le cose fossero successe proprio davanti ai loro occhi. A quello ci tenevo proprio. Ci sono giochi con meccaniche che favoriscono i giocatori più schematici, quelli che giocano per affermare sé stessi o per fare il culo all’avversario. In Bruti ho cercato di fare in modo che sconfitta e vittoria diano quasi la stessa soddisfazione. Questa cosa della narrazione, tra l’altro, non l’ho comunicata con chiarezza durante il lancio del gioco, e a ripensarci ora sono stato stupido, avrei dovuto dirlo chiaramente: «Bruti è un generatore di storie». Fortunatamente il messaggio in qualche modo è arrivato lo stesso, e per me è stata un’enorme soddisfazione.
Andrea Peduzzi: Qualche anno fa hai diretto un film, L’ultimo terrestre. Come hai gestito in quel caso il rapporto tra cinema e fumetto? Il tuo background è stato decisivo o sei partito dalle basi?
Gipi: Quando mi sono avvicinato al cinema non avevo sulle spalle una vera esperienza professionale, eppure avevo già pasticciato con qualche cortometraggio e un paio di film auto-prodotti. Mio padre mi ha regalato la prima cinepresa Super 8 e una centralina di montaggio (di quelle con scotch e taglierino) che avevo solo sei anni, quindi in qualche modo ho sempre avuto la testa nelle inquadrature. Da ragazzino filmavo i miei amici mentre giocavano ai cowboy, e fare un film “vero” è sempre stato il mio sogno. Così, quando il sogno è diventato realtà, ho cercato di prepararmi al meglio delle mie possibilità: ho studiato, ho letto tutto quello che potevo leggere. Eppure, come diceva Kubrick, i film li impari facendoli. Solo quando sei sul set a coordinare persone che ti danno il loro tempo, che seguono assieme a te la sceneggiatura, la scenografia, l’illuminazione, il montaggio il sonoro e tutto quanto il resto, capisci veramente come girano le cose. Il primo giorno mi sono sentito come un cowboy straniero che entra nel saloon e viene squadrato dalla gente del posto (fuor di metafora, tutte le maestranze esperte della troupe). Ho esordito con un piano di lavorazione piuttosto impegnativo, con tanto di dolly e carrello. Quando l’ho esposto alla troupe, tutti mi hanno guardato come a dire «See, mo’ è arrivato l’artista». Quello che non sapevano è che avevo passato i due mesi precedenti a fare delle prove nel posto dove avrei girato, e mi ero preparato al massimo delle mie possibilità. Durante la prima giornata delle riprese, riusciamo a girare tutta la roba in programma, e chiudiamo addirittura con un’ora di anticipo; da quel momento in avanti, tutti mi hanno portato rispetto. Ho avuto una troupe meravigliosa, che mi ha sempre spinto a farmi il culo e a dare il massimo. La notte preparavo bene gli storyboard - il disegno era l’unica arma segreta che avevo - e cercavo di arrivare sul set sempre ben preparato.
Poi, per carità, a riguardarlo ora il film è venuto statico, senza invenzioni, pieno di cose storte. Per una serie di motivi, credo che durante la lavorazione abbia preso il sopravvento la mia parte più umile e, col senno di poi, sono molte cose le potevo spingere di più. Va’ detto che fare un film in Italia, con i budget che vengono stanziati, è una cosa eroica. Io stesso, prima di questa esperienza, ero molto critico nei confronti del cinema italiano. Poi, quando mi sono trovato a dover girare venti scene in un giorno, mi sono sentito un po’ come René Ferretti. Sarà banale come considerazione, ma da noi mancano le risorse, e il cinema - o quantomeno un certo tipo di cinema, strutturato, con la troupe “vera” e tutto il resto - è legato a doppio filo al budget, che giocoforza blinda tutto l’immaginario del regista.
Eppure, per me, già essere uscito vivo dalla lavorazione senza aver sforato sui tempi, e dopo essermi guadagnato l’amicizia e il rispetto della troupe, è stato bello. In quel senso credo di aver ottenuto un buon risultato.
Andrea Peduzzi: Nelle tue opere, da alcuni dialoghi o concetti - mi viene in mente un passaggio da Una Storia: «Del resto tu non vai al mare. Parli del mare» - emerge una forte diatriba tra il cosiddetto mondo reale e il quello astratto dei racconti. Immagino sia uno stato mentale comune a molti artisti: Truffaut, ad esempio, era solito mettere sullo stesso piano le esperienze mediate e quelle reali. Qual è il tuo rapporto con la realtà? Pensi di viverla pienamente?
Gipi: Non so se questa sorta di “negazione della realtà” sia cosa diffusa tra chi campa di storie, però penso che tutto sommato sia una distorsione: perché mai qualcuno dovrebbe preferire raccontare le cose, anziché viverle? Eppure, in questa trappola ci sono cascato anch’io, nonostante conoscessi il trucco.
Sono sempre stato di indole piuttosto statica: fosse per me, non vorrei mai andare da nessuna parte. Piuttosto che muovermi, magari mi metto a scrivere la storia di uno che vive su Titano. È una cosa che mi porto dietro fin dall’infanzia. Secondo me ci sono due tipi di ragazzini: quelli che prendono i soldatini e li strapazzano e quelli che li muovono al rallentatore, immaginandosi mille storie. Io ho sempre fatto parte della seconda categoria, ho sempre seguito più facilmente la via della rappresentazione, anziché quella dell’azione.
Eppure, ogni volta che in vita mia ho avuto l’energia e il coraggio per rompere il muro della passività e muovere il culo, devo ammettere che è stato bello. Quando ho navigato davvero su una barca a vela, anziché immaginarmelo, è stato fantastico. Mi ha fatto meglio al cervello, al fisico, alla pelle, rispetto allo stare chiuso in una stanza a fare fumetti o a leggere.
Poi, come ho già detto, la maggior parte dei miei libri nasce sulla scorta di esperienze dirette che ho accumulato quando stavo per strada a vivere, anziché disegnare. La prima giovinezza ha rappresentato il mio bagaglio narrativo per vent’anni e difficilmente avrei avuto storie da raccontare standomene in casa. Di contro, col passare del tempo si è fatto sempre più difficile continuare a parlare di certe cose, anche perché oggi sono sostanzialmente un cinquantenne piccolo-borghese. Se avessi continuato a sfruttare il mio bagaglio giovanile mi sarei sentito male, e probabilmente avrei partorito delle porcherie inutili. Eppure, ogni volta che mi lancio in qualche avventura devo vincermi: per i prossimi giorni, ad esempio, ho in programma un viaggio di lavoro in Corea, e ho una paura boia. Pensa che ho deciso di interrompere Zelda su Switch per tenermelo come distrazione per la traversata in areo, che mi terrorizza.
Andrea Peduzzi: In effetti, già che hai tirato in ballo Zelda, dalle tue opere emerge una certa dimestichezza con la guerra simulata, con gli sparatutto in prima persona e più nello specifico con i videogiochi: in Appunti per una storia di guerra c’è persino un riferimento a Battlefield. Quanto apprezzi i videogiochi? Considerato che oltre ai fumetti hai già sperimentato altre forme di racconto, ci lavoreresti pure sopra, a un videogame?
Gipi: Apprezzo moltissimo i videogiochi, e sì, ci lavorerei pure sopra a occhi chiusi. Tra i titoli recenti che mi hanno preso metto The Last of Us, che sul piano narrativo ho trovato di una potenza mostruosa. Il gioco che attualmente mi sta più sul cazzo, invece, è Battlefield 1; trovo che gli sviluppatori abbiano fatto una cosa veramente immorale, appiccicandoci sopra questa lezioncina ipocrita: “La guerra è orribile, guardate quanto è orribile la guerra”, per poi spingere su meccaniche che dicono esattamente l’opposto. In giro ci sono sparatutto come Red Orchestra 2, o Rising Storm 2: Vietnam, di cui ho sperimentato la beta, che magari non fanno tanti pipponi, ma offrono un’esperienza di gioco talmente terrificante da farti stare male, da farti pensare «Porca troia, speriamo che non mi capiti mai». Io nei videogiochi e nei giochi in generale posso accettare di tutto, anche di fare il serial killer, ma la lezioncina morale di Battlefield 1 mi è parsa veramente una paraculata.
Se scegli di rappresentare la guerra, piuttosto fallo alla Spielberg. In salvate il soldato Ryan, alla fine dello sbarco in Normandia, il personaggio di Tom Hanks guarda lo scenario e esclama “che spettacolo”, mettendo addosso allo spettatore un senso di colpa tremendo, perché solo un attimo prima era immerso fino al collo in tutta quella messa in scena grandiosa e affascinante. Un autore non dovrebbe mai dimenticare di fare i conti con l’orrore della guerra, ogni volta che la rappresenta.
Io, poi, sono particolarmente fissato con certe cose. Mi sono letto un sacco di libri sui conflitti più disparati, soprattutto storie di sopravvissuti, che in genere raccontano giorni e giorni di noia spezzati da dieci minuti di terrore purissimo. Resto affascinato dall’uomo che si confronta con la morte nel modo più ravvicinato possibile; soprattutto, mi affascina il tema della vicinanza di sangue che si crea tra i compagni d’armi. C’è un libro stupendo che si chiama The Good Soldiers (I bravi soldati), scritto dal giornalista e premio Pulitzer David Finkel, incentrato sulle esperienze dei soldati al fronte. È un libro straziante, eppure, paradossalmente, ruota attorno al tema della fratellanza. Forse sono un po’ retrogrado, ma la tematica della solidarietà in armi mi affascina, per quanto speri di non avere mai a che fare con la guerra.
Credo di essere stato segnato da un racconto trasmessomi da mio padre: durante la Seconda Guerra Mondiale, lui e il cugino di mia madre incapparono in un nido di mitragliatrici nascosto in un fienile che credevano abbandonato, in mezzo a un campo di grano. Quando i mitra attaccano a sparare, i due sono costretti a separarsi per trovare rifugio tra le buche di un precedente bombardamento; eppure, mentre i proiettili ancora fischiano, entrambi a turno tirano fuori la testa per vedere se l’altro è vivo. Questo per me rappresenta il senso più puro della fratellanza.
Andrea Peduzzi: Oggi si fa un gran parlare di realtà virtuale: dopo anni di fantasticherie, sono arrivati in commercio i primi dispositivi abbordabili, che hanno attirato l’attenzione di game designer, registi e animatori. Il lancio del dispositivo PlayStation VR è stato accompagnato da un corto d’animazione, Allumette, mentre Pearl, di Patrick Osborne, è stato addirittura candidato agli Oscar. Come artista, sei attratto dalle possibilità dei mondi virtuali? Li hai mai sperimentati?
Gipi: Eccome se li ho sperimentati. In casa ho un visore PlayStation VR e mi sono fatto tutto l’ultimo Resident Evil cagandomi addosso dalla paura. Di recente, un amico mi ha fatto provare uno degli accrocchi di Samsung (Gear VR, ndr), mostrandomi un documentario sugli immigrati, No Borders, nel quale la prospettiva del fruitore è libera. La VR è una cosa perfettamente nelle mie corde: l’idea di poter girare un film a trecentosessanta gradi, senza troupe, dove tutto è campo, tutto è azione, mi affascina tantissimo e sposa pienamente la mia filosofia di libertà. Soprattutto, mi attira la possibilità di costruire un tipo di narrazione nella quale lo spettatore possa finire col perdersi le azioni salienti. Nel 2002 ho realizzato un cortometraggio intitolato Da un’altra parte, nel quale racconto la storia di due ragazzi che si indebitano per comprare una cinepresa e girare un film. Solo che poi, quando piazzano l’attrezzo sul cavalletto, tutto finisce col succedere sempre un metro fuori dalla loro inquadratura. Quindi l’idea, ad esempio, di costruire un dialogo tra due attori mentre fuori campo sta succedendo l’impossibile, a me piace molto.
Andrea Peduzzi: Se tu fossi un game designer, o comunque se decidessi di proporre un’esperienza virtuale, punteresti su una rappresentazione antropomorfa dell’avatar, o gestiresti la cosa in maniera astratta - luce/movimento/suono - come professato dai puristi del cinema d’animazione?
Gipi: Guarda, io ho la fissa dell’estremo realismo, quindi sceglierei senz’altro di infilare il fruitore in un corpo “vero”, in tre dimensioni, con braccia, gambe e tutto il resto, e con una gestione della fisica credibile. In questo senso sono un po’ alla vecchia: più mi avvicino alla realtà, più sono contento.



Andrea Peduzzi: Per la sezione Spazio del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci hai realizzato degli artwork basati sul videogioco Destiny. Conoscevi già il gioco? Come ti sei mosso per la creazione degli artwork, sul piano compositivo e artistico? Hai avuto la possibilità di confrontarti con Bungie?
Gipi: No, non conoscevo il gioco, ma ho avuto modo di provarlo grazie ad Activision, che me l’ha gentilmente mandato, e devo dire che dell’esperienza ho apprezzato soprattutto il design delle creature, davvero figo.
Nel realizzare gli artwork per il MUST mi sono divertito a confrontarmi con quel particolare stile di disegno, proprio perché è quasi agli antipodi rispetto al mio. Lavorare sul materiale pensato dagli degli artisti di Bungie mi ha fatto bene, così come mi fa bene qualsiasi esperienza da disegnatore lontana dalla mia natura. Per il resto, il lavoro l’ho realizzato da solo, in autonomia, senza un confronto diretto con gli sviluppatori e senza una direzione imposta: ho disegnato colorato e interpretato l’estetica di Destiny secondo la mia sensibilità.
Andrea Peduzzi: Un’ultima richiesta: disegneresti per Outcast qualcuno dei tuoi personaggi mentre sbotta in uno «STOCAZZO»? In alternativa, se preferisci, puoi pure fargli dire «Ringcast merda».
Gipi: Stocazzo va benissimo.
Foto e video: Gipi, Coconino Press, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.