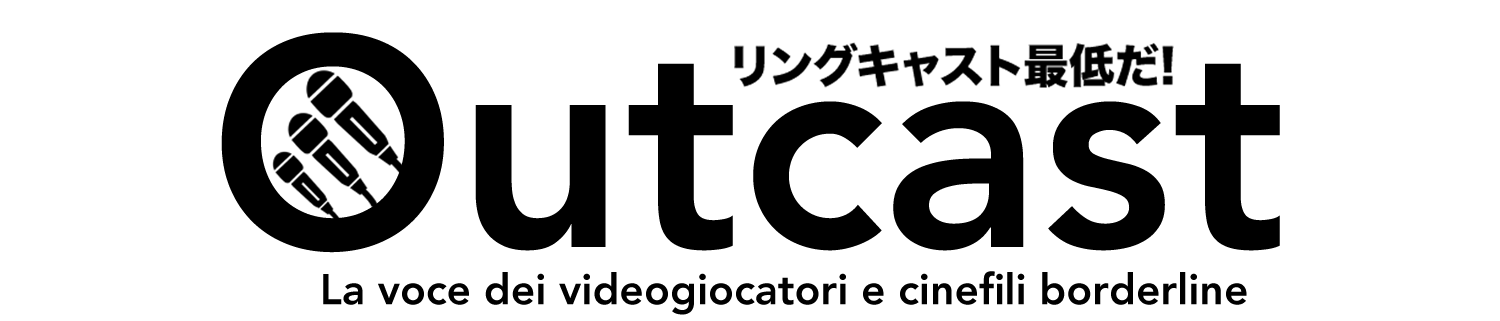Ray Donovan come (splendida) metafora della vita
Quante cose cambiano in un anno. È passato tanto, su per giù, da quando ho pubblicato il mio primo articolo per Outcast, una recensione della quarta stagione di Ray Donovan. Nel frattempo, tante cose su queste pagine sono cambiate, con l’introduzione delle Cover Story che ha portato nuova linfa vitale alla “piattaforma” (citazione per pochi). E anche Ray Donovan, nel mentre, si è evoluto; anche lui in meglio. “La sensazione è che Ray Donovan abbia preso quella triste strada percorsa dalle serie TV che ormai hanno poco da dire, ma vanno comunque avanti quasi per inerzia”, scrivevo il 27 settembre di un anno fa, scocciato e un po’ deluso da una serie che in passato mi aveva dato tanto, ma che in quella stagione sembrava stanca, complice forse anche l’addio della creatice Ann Biderman, e in procinto di chiudersi senza quei sussulti emozionali che l’avevano caratterizzata. Ebbene, mi sbagliavo. David Hollander, nuovo principale showrunner della serie, è riuscito a mettere tutto in discussione, grazie a scelte coraggiose, di trama e di regia, che hanno rinnovato Ray Donovan come quasi nessuno credeva ormai possibile.
Una fra le accuse che più di frequente sono state mosse alla serie di Showtime è quella di essere un prodotto derivativo, una di quelle produzioni audiovisive che si rifanno apertamente ad altri esponenti della categoria d’appartenenza, modificando e aggiustando giusto qualche elemento qua e là – leggasi I Soprano. La critica è parzialmente fondata, ma anche se lo fosse nella sua totalità, non ci vedrei nulla di male. Da sempre ogni prodotto mediale, magari con velleità artistiche, si rifà a qualcosa che l’ha preceduto. Poi sì, c’è chi rivoluziona, inserendo elementi totalmente inediti, e c’è invece chi, quest’operazione, la fa solo in parte. È il risultato, semmai, che va discusso. Così Umberto Eco, in Sulla letteratura (Bompiani, 2002): “Quando si dice che non c’è idea in Borges che non ci fosse già prima, si dice che non c’è una sola nota in Beethoven che non fosse già stata prodotta prima. Quello che rimane fondamentale in Borges è la sua capacità di usare i più svariati detriti dell’enciclopedia (nell’accezione echiana del termine, ndr) per fare musica di idee”. Ray Donovan, insomma, si rifà apertamente ai Soprano, e non c’è affatto nulla di male. In questa stagione più che mai, gli sceneggiatori di Showtime si sono ispirati all’indagine intima più surreale che ha caratterizzato l’epopea di Tony Soprano, riuscendo a tratteggiare un quadro che riesce a sviscerare, nuovamente, l’animo del proprio protagonista, sotto una luce questa volta diversa.
Occhio: nei prossimi due paragrafi si analizzano alcune svolte specifiche della quinta stagione. Se non l'avete vista e preferite evitare spoiler, passate al paragrafo conclusivo.
Il pretesto per mettere in scena questo moto interiore in Ray, e che darà poi il là a tutta una serie di conseguenze tutt’altro che prevedibili, è la morte di Abby, sua moglie. Una donna che ha subìto tanto, nelle stagioni precedenti, e che in questa quinta annata si ripresenta, per un’ultima volta, all’interno di una prospettiva nuova, con una presenza costantemente assente che trae in inganno lo spettatore e lo stesso Ray. Durante i primi episodi non è mai chiaro se quello che noi stiamo vedendo, attraverso gli occhi di Ray, sia un’illusione oppure una semplice constatazione di eventi realmente accaduti. La narrazione si mischia all’analessi confondendo, e rendendo chiaro solo con l’incedere degli eventi, che quello a cui stiamo assistendo non è un sogno, quanto piuttosto la rappresentazione della realtà vissuta dal protagonista, il cui quotidiano dramma interiore non può prescindere da un lutto tutt’altro che assimilato. Ed è quasi paradossale, in tutto ciò, come il costante galleggiare fra realtà e sogno includa anche visioni più angoscianti, quasi degli incubi, che fatichiamo ad assimilare come realmente accaduti; troppo brutti, per essere veri.
Verso il finale di stagione, tuttavia, questa narrazione stratificata ha modo di evolversi in corso d’opera, nuovamente, questa volta in chiave onirica, e come unica costante quella di Abby. Di più: la moglie di Ray è una sorta di Virgilio, che ci guida all’interno dei processi interni di Ray; ma lo capiamo solo un po’ alla volta, grazie alla sua estetica, che cambia in base al ricordo, al sogno o all’incubo che il marito sta vivendo, mentre si muove in una realtà che l’ha svuotato dal di dentro. E, forse anche per questo, nella prossima stagione la serie cambierà location, spostandosi da Los Angeles, con i suoi spazi aperti nei cui punti d’ombra Ray si muoveva tanto facilmente, alla ben più caotica New York. Dopo un twist come la morte di Abby, un cambiamento così drastico era forse necessario per il bene della serie.
Ci sarebbero moltissimi altri appunti da annotare, su questa quinta stagione di Ray Donovan. Come ad esempio la meta-testualità nel citare, quasi involontariamente, l’attualità del caso Weinstein; oppure l’ennesimo nuovo-vecchio tratteggio di Mickey, padre di Ray, personaggio estremamente affascinante nella sua ambiguità; o ancora quella mise en abyme rappresentata dal fidanzato di Bridget, figlia di Ray, attraverso il quale si consuma, in una sorta di intertestualità, la tragedia del cancro, che attraversa trasversalmente la famiglia Donovan. Per usare le parole di Christian Raimo: “La letteratura o è conflitto, o è spiazzamento, o non è: è inutile”. Allargando il discorso, si potrebbe dunque dire che, a dispetto del suo essere più o meno derivativo, anche Ray Donovan rientra in quest’ottica, e questa sua quinta stagione, che spiazza a più riprese, ne è la prova.
Ho visto Ray Donovan in modo piuttosto sconclusionato, fra episodi guardati a singhiozzo e maratone più o meno traumatiche, sul Netflix italiano, che pubblicava settimanalmente, a distanza di due giorni, l'episodio andato in onda ogni domenica su Showtime. Probabilmente, come accaduto in passato, anche questa quinta stagione di Ray Donovan arriverà prossimamente su Rai 4.